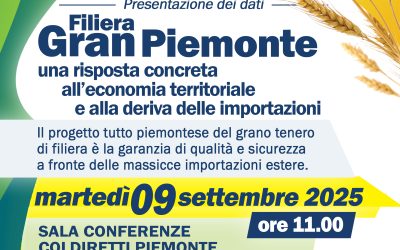I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono parte della quotidianità scolastica d’oggi. Per questo meritano un approfondimento volto a chiarire i dubbi e fare il punto su come la scuola si organizza per dare soluzione alle aspettative dei ragazzi, delle famiglie e della classe. Ne ho parlato con l’insegnante di scuola primaria Elda Rinaudi, laureata in pedagogia, specializzata in Didattica e psicopedagogia per i DSA che svolge la Funzione Strumentale per gli alunni con BES sanitari presso l’I. C. “Isoardo-Vanzetti” di Centallo.
La docente ha anche collaborato con la Rete genitori DSA di Cuneo alla stesura del libretto divulgativo “Io al posto tuo – Cosa so dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale.
D. – Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento?
R. – I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) fanno parte di un gruppo di disturbi di origine neurobiologica che interferiscono con il normale apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo. Non sono causati né da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali. Non sono una malattia in quanto non sono dovuti a un danno organico, non derivano da mancanza di studio, di applicazione ed impegno, ma dipendono da un “diverso funzionamento” del cervello nelle specifiche aree cerebrali deputate alla lettura, alla scrittura e al calcolo. Nelle persone con DSA, la costituzione neurologica che dà luogo ai neuroni ed alle connessioni che si creano tra loro, è lievemente diversa rispetto alle persone definite “normotipiche”. Ciò non impedisce la realizzazione della specifica abilità di lettura, di scrittura o di calcolo, ma questa, necessita di tempi più lunghi e richiede carichi attentivi maggiori con conseguente affaticamento del soggetto e probabile presenza di reazioni emotive negative (crisi di pianto, comportamenti oppositivi e di evitamento) che si manifestano quando devono essere svolti i compiti scolastici.
D. – Quali sono questi Disturbi Specifici dell’Apprendimento?
R. – I disturbi che rientrano nella categoria diagnostica dei DSA sono quattro:
dislessia, disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella trasformazione dei segni grafici nei suoni che compongono le parole del testo;
disortografia, disturbo specifico della scrittura che consiste in una difficoltà nel tradurre correttamente i suoni in simboli grafici seguendo la corretta regola ortografica;
disgrafia, disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell’abilità motoria della scrittura;
discalculia, disturbo specifico che va ad inficiare la capacità di comprendere ed operare con i numeri.
Occorre ricordare che, non sempre, i DSA si presentano in modo isolato, ma non è rara la compresenza di più DSA nella stessa persona o la presenza di un DSA in comorbilità con il deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
D. – C’è la possibilità di una diagnosi precoce per i DSA?
R.. – Le Linee Guida che sono il documento che stabilisce criteri e procedure per la diagnosi ed il trattamento dei DSA, affermano con chiarezza che solo al termine del secondo anno di scolarizzazione è possibile pervenire ad una diagnosi certa di DSA, fermo restando che nel corso dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del 1°anno di frequenza della scuola primaria è possibile individuare nel bambino dei “campanelli d’allarme” che possono essere “predittori” del futuro sviluppo di un DSA, senza tuttavia indicare una certezza. Pur nelle variabilità delle singole situazioni, solitamente, la diagnosi di dislessia e disortografia avviene durante il 2°quadrimestre della seconda classe primaria mentre la diagnosi di discalculia e disgrafia avviene al termine del terzo anno di primaria.
D. – Cosa succede se la diagnosi è tardiva?
R. – La diagnosi tardiva effettuata in età adolescenziale o in età adulta, spesso, condiziona pesantemente le scelte scolastiche e lavorative della persona con DSA. In ambito scolastico, il mancato riconoscimento del disturbo, infatti, può portare ad una maggiore probabilità di esperienze di insuccesso che si accompagna a sentimenti di diversità, di inadeguatezza e di insicurezza con calo di autostima. La sofferenza e il disagio legati ai fallimenti vissuti scatena, con il tempo, comportamenti disfunzionali quali tratti d’ansia e la tendenza ad assumere ruoli aggressivi. Pur impegnandosi, questi studenti, non sentono di essere valutati effettivamente per le loro capacità. Spesso sono ritenuti sfaticati, distratti o poco intelligenti e crescono con la convinzione di essere “sbagliati”. In alcuni casi anche le loro relazioni familiari non sono soddisfacenti in quanto compromesse dall’andamento scolastico non sempre positivo.
D. – Come può la scuola promuovere l’inclusione per gli studenti con DSA?
R. – L’inclusione scolastica ha lo scopo di condurre tutti gli alunni di una classe a raggiungere il loro massimo livello di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze che vengono accolte, stimolate, valorizzate, utilizzate come risorsa per la crescita del singolo e dell’intera classe attraverso metodologie attive, partecipative e costruttive che tengano conto delle varie forme di intelligenza, dei diversi stili cognitivi, delle peculiarità legate ai diversi disturbi e degli aspetti emotivi che caratterizzano ciascun individuo.
D. – Quali tipi di supporto scolastico sono proposti per gli alunni con DSA?
R. – L’articolo 5 della Legge 170 si occupa delle misure educative e didattiche di supporto all’apprendimento e indica che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” nell’ambito di una didattica individualizzata e personalizzata, che tenga conto delle caratteristiche e dei punti di forza dello studente in una dimensione inclusiva che richiede un ambiente scolastico in cui tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche, vengano valorizzati ed abbiano pari opportunità di apprendimento e di socializzazione.
D. – Puoi parlarci degli strumenti compensativi e del loro utilizzo in classe?
R. – Gli strumenti compensativi, così come definiti dalla legge 170/2010, sono dispositivi cartacei o digitali che “sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”, sia essa la scrittura, la lettura o il calcolo e permettono al bambino o al ragazzo di studiare e apprendere con efficacia, con sempre maggiore autonomia. Gli strumenti compensativi si chiamano così perché compensano le difficoltà di lettura, scrittura o calcolo legate agli “automatismi di base” così come un paio di occhiali compensa le difficoltà della vista. L’uso degli strumenti compensativi non avvantaggia il bambino con DSA rispetto ai compagni, ma riduce soltanto il carico di fatica nello svolgere compiti legati agli automatismi di base.
D. – Quanto importante, in questo contesto, la formazione degli insegnanti?
R. – La formazione docente assume un ruolo cruciale. La legge 170/2010, che regola l’inclusione degli alunni con DSA nel sistema scolastico italiano, sottolinea l’importanza di adottare modalità didattiche adeguate per garantire a tutti gli studenti la possibilità di buoni livelli di apprendimento in un ambiente che favorisca la piena espressione delle potenzialità di ciascuno e il raggiungimento un buon livello di autostima e autoefficacia personale. La formazione dei docenti in questo contesto deve perciò concentrarsi sia sull’identificazione e sull’intervento nei confronti dei DSA sia sull’implementazione di una didattica inclusiva che adotti un approccio che tenga conto della diversità come valore e risorsa, piuttosto che come ostacolo.
D. – Concluso il ciclo scolastico, quali percorsi lavorativi possono essere più adatti per le persone con DSA?
R. – Rispetto alle persone “normotipiche”, le persone con DSA, generalmente, sono empatiche, hanno maggiore perizia nell’elaborare informazioni visive e spaziali, sono intuitive ed abili nel problem solving e dotate di creatività. Il loro funzionamento cognitivo non convenzionale, consente di adottare punti di vista originali e soluzioni non lineari ai problemi. Pertanto, le attività lavorative più consone sono quelle che richiedono la messa in gioco delle qualità ed abilità sopra citate.